Viaggio in Sicilia
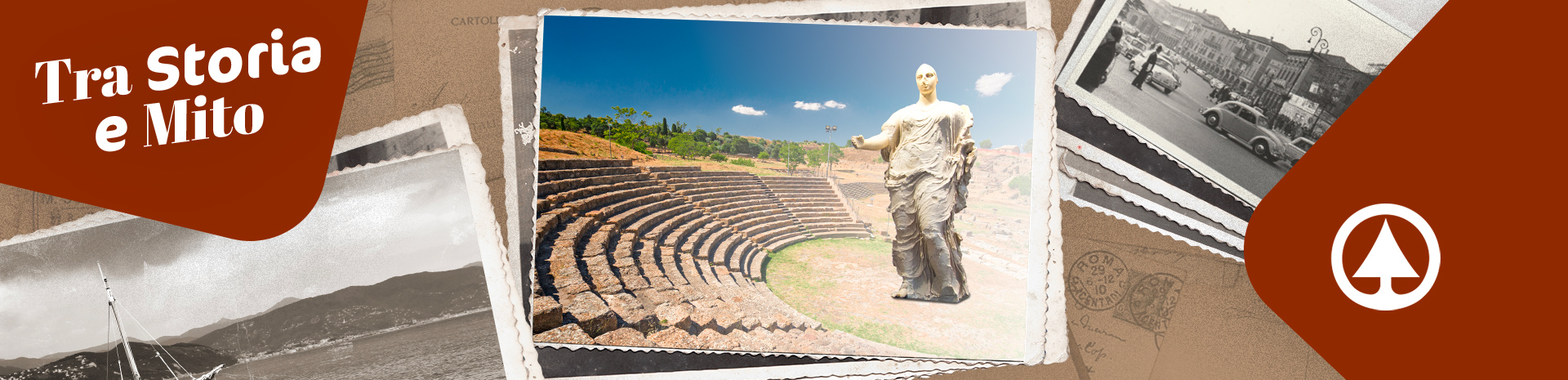
Morgantina e la sua Dea
C’è un luogo, tra le colline dell’entroterra siciliano, dove il silenzio racconta più delle parole. È Morgantina, antica città siculo-greca nascosta tra i declivi della provincia di Enna, nel territorio di Aidone. Qui, dove il sole accarezza pietre antiche e il vento sembra conoscere tutte le storie, riposano i resti di un passato glorioso: teatri, agorà, case aristocratiche e terme ancora segnate dalle mani del tempo. Morgantina fu un importante centro tra il V e il I secolo a.C., abitato da Siculi, Greci, poi Romani. Un luogo di scambi, cultura, raffinatezza. Ed è proprio in questo scrigno di storia che venne alla luce uno dei più straordinari reperti archeologici del Mediterraneo: la Dea di Morgantina, una colossale statua in marmo e calcare alta oltre due metri, risalente al V secolo a.C.
Il ritorno della bellezza rubata
Non ci fu clamore, all’inizio. Nessun annuncio ufficiale, nessun corteo di archeologi. La Dea venne dissotterrata in modo clandestino, di notte, trafugata dal cuore della Sicilia rurale e portata via. A scoprire il furto furono anni dopo gli studiosi. Nel 1988 la statua fece la sua comparsa nelle sale del Paul Getty Museum di Malibù, in California. Ma qualcosa non tornava: quell’opera aveva il respiro della Sicilia, il profumo della sua polvere antica. Nel 2001, il Tribunale di Enna scrisse una pagina fondamentale della giurisprudenza italiana, condannando il ricettatore ticinese Renzo Canavesi al carcere e al pagamento di una sanzione ingente, la prima così rilevante nella storia italiana per l’esportazione clandestina di un reperto archeologico. Fu un lungo viaggio quello che la riportò a casa. Tra studi, battaglie legali e la determinazione di archeologi e funzionari, nel 2011 la Dea tornò ad Aidone, dove venne esposta al pubblico nel Museo Archeologico del luogo.
Un volto tra umano e divino
Alta circa 2,20 metri, realizzata in marmo pario e calcare locale, la Dea di Morgantina è imponente. Il panneggio delle vesti, mosso da un vento immaginario, aderisce al corpo con grazia e potenza, in un equilibrio perfetto tra armonia e forza. Anche la parte posteriore della statua è riccamente lavorata: forse la Dea era collocata su un piedistallo, visibile da più angolazioni. Il retro della testa, invece, non è rifinito: un indizio che potrebbe suggerire la presenza originaria di un copricapo o di una parrucca. Il volto, perduto nei secoli, lascia spazio all’immaginazione: chi era? Demetra, dea della terra e dei raccolti? Oppure Persefone, figlia rapita e regina degli Inferi? Entrambe divinità profondamente legate a Morgantina, entrambe al centro di culti e rituali legati al ciclo della natura e della rinascita. Il mistero della sua identità non fa che accrescerne il fascino. I materiali, le tecniche scultoree, lo stile severo ma fluido, raccontano di una maestria tipica dell’arte greca classica, dello stile diffusosi durante il periodo della guerra del Peloponneso. A realizzarla probabilmente un artista attico, forse uno degli allievi di Fidia, celebre scultore dell’antichità.
La Dea di Morgantina non è solo un’opera d’arte. È simbolo di bellezza ferita e ritrovata, di un’identità strappata e infine restituita. È il volto di una Sicilia che lotta per conservare la propria memoria e raccontarla al mondo.




